Chi insegna scienze lo sa bene: ci sono argomenti che accendono subito la curiosità degli studenti… e altri che, nonostante il loro potenziale, rischiano di apparire terribilmente noiosi.
I minerali – e con loro le rocce – spesso finiscono in questa seconda categoria. Non certo perché manchino di fascino, ma perché, quando vengono affrontati solo in termini teorici, rischiano di rimanere scollegati dalla realtà quotidiana degli studenti.
La letteratura pedagogica ce lo ricorda chiaramente: secondo Bransford, Brown e Cocking (2000), nel loro volume “How People Learn: Brain, Mind, Experience, and School”, l’apprendimento significativo si sviluppa quando i nuovi concetti si radicano in esperienze autentiche e rilevanti per chi apprende.
E infatti, chi ha avuto modo di proporre questo tema attraverso attività pratiche e approcci investigativi sa bene quanto possa trasformarsi in un’esperienza viva, multisensoriale e sorprendentemente coinvolgente.
“Prof, ma a cosa ci serve studiare queste cose?”
Una domanda che ci sentiamo fare spesso, non è vero? Eppure, nel caso dei minerali, possiamo facilmente rispondere con esempi immediati, quotidiani, vicini alla vita reale.
I minerali sono ovunque: nella grafite della matita, nel sale da cucina, nei vetri, nei telefoni, nei cosmetici, nei gioielli, nei farmaci. Aiutare gli studenti a scoprirlo significa guidarli a “vedere” la scienza nel mondo che li circonda, un passaggio chiave per dare senso agli apprendimenti (Osborne & Dillon, 2008).
Basta una semplice domanda per accorciare le distanze tra ciò che si studia e la realtà che li circonda: “Riuscite a trovare cinque oggetti nel vostro zaino o in aula che contengano minerali?” Da qui può partire un viaggio di scoperta autentico.
Lasciamo che siano loro a esplorare
Quando affronto i minerali in classe, io parto dall’esperienza con l’osservazione libera. Gli studenti toccano, osservano, confrontano e discutono tra loro. Usano il loro linguaggio per descrivere ciò che vedono. Attivano le preconoscenze e si incuriosiscono.
È proprio dopo l’osservazione iniziale che lo sguardo degli studenti cambia. Non si accontentano più di descrivere ciò che vedono: iniziano a chiedersi il perché. E da lì, la scienza prende forma.
“Perché due minerali che sembrano uguali si comportano in modo così diverso quando li testiamo?”
“Che cosa ci dice davvero il colore? È una proprietà affidabile o può ingannare?”
“Perché alcuni si sfaldano con superfici perfette mentre altri si rompono in modo irregolare?”
“Come fa una semplice reazione con il succo di limone a rivelarci qualcosa sulla composizione chimica?”
“E se riesce a graffiare il vetro… quanto è forte davvero quel cristallo?”
Domande che vanno oltre il “cosa vedo” e toccano il “come funziona” e il “perché accade”. Domande che costruiscono conoscenza, passo dopo passo, su basi solide, concrete, esperienziali. È lì che la curiosità si trasforma in comprensione e il sapere prende forma. Secondo l’approccio IBSE (Inquiry-Based Science Education), infatti, il coinvolgimento diretto con i fenomeni favorisce il pensiero critico, la formulazione di ipotesi e la riflessione autonoma (Harlen, 2013).
Il linguaggio scientifico? Lo costruiscono loro
Uno dei momenti più gratificanti è vedere i ragazzi passare da un “mi sembra lucido” a un “ha lucentezza vitrea”. Non è solo un tecnicismo: è la dimostrazione che quel termine ha preso senso attraverso l’esperienza, è stato interiorizzato, vissuto.
Quando poi iniziano a confrontare, classificare, ipotizzare… stanno davvero facendo scienza. Stanno ragionando come piccoli geologi. Stanno imparando con la testa, con le mani e con le parole.
I minerali come chiave per capire il mondo
Lo studio dei minerali non si limita alla geologia: è una porta d’accesso privilegiata per discutere di sostenibilità, tecnologia, risorse naturali, economia, equità.
Attraverso i minerali, gli studenti possono iniziare a comprendere il legame tra scelte quotidiane e processi globali, tra ciò che usano e ciò che (spesso inconsapevolmente) sfruttano.
Ed è proprio in questo spazio che nascono alcune delle domande più significative.
“Se ogni smartphone contiene decine di minerali, dove li prendiamo tutti? E a che costo?”
“Perché certi minerali sono considerati ‘critici’? Chi decide quali sono davvero indispensabili?” “Cosa succede quando una risorsa naturale si esaurisce? Chi ne paga le conseguenze?”
“Possiamo parlare di sostenibilità se l’estrazione dei minerali distrugge ecosistemi o comunità?”
“Davvero possiamo capire l’interno della Terra osservando questi campioni?”
Domande che non hanno risposte immediate, ma che stimolano ricerca, confronto e consapevolezza e che ci ricordano che insegnare scienze della Terra è anche educare alla cittadinanza scientifica e ambientale.
Un passo alla volta, senza bisogno di strumenti complessi
Uno degli ostacoli più comuni quando si affrontano le scienze della Terra (e le scienze in generale) in modo attivo è la convinzione di dover disporre di strumenti avanzati o di un laboratorio perfettamente attrezzato. Ma la realtà è che non servono tecnologie o strumenti sofisticati per fare scienza in classe.
Bastano pochi materiali essenziali — una piastrella da striscio, una calamita, un vetrino, un limone (o un acido debole) e una struttura didattica chiara, accessibile e investigativa.
Con un approccio ben progettato, possiamo:
– guidare l’osservazione e la classificazione attraverso domande autentiche
– facilitare l’esplorazione delle proprietà fisiche con test semplici
– stimolare il confronto tra ipotesi e dati raccolti
– costruire insieme il linguaggio scientifico, passo dopo passo
– adattare il percorso all’età, ai tempi e ai contesti delle nostre classi.
Il cuore del percorso è sempre lo stesso: l’esperienza diretta, il desiderio di capire partendo dall’osservazione e il piacere di scoprire che anche “un sassolino” può raccontare storie affascinanti, se impariamo ad ascoltarlo con gli strumenti giusti e con occhi curiosi.
Se stai cercando un punto di partenza concreto, che unisca attività esplorative, strumenti semplici e una guida passo passo, puoi trovare un percorso già pronto sulla mia pagina Eduki: “Conoscere i minerali”
Il percorso è pensato per essere flessibile, adattabile e facilmente integrabile nella didattica quotidiana in tutti i livelli di scuola.
E tu? Quali strategie utilizzi per rendere lo studio dei minerali più coinvolgente?
Le tue esperienze possono ispirare altri insegnanti. Se ti va, condividile nei commenti!
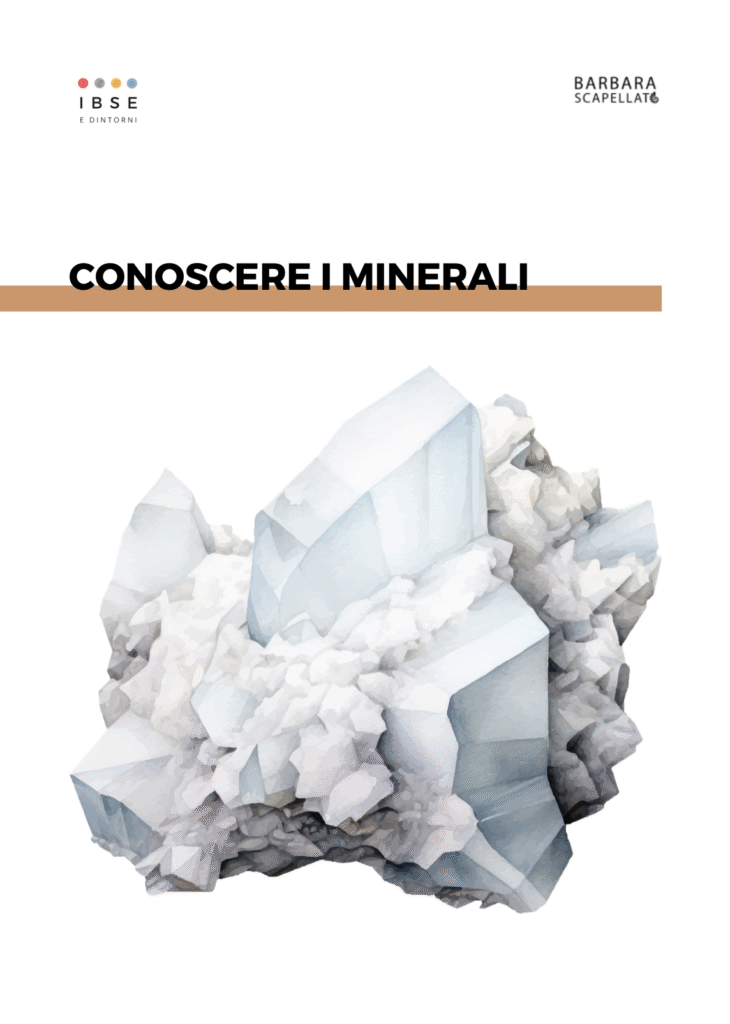


Eduki cosa contiene?
Ciao! Eduki è una piattaforma dove i docenti possono acquistare (o vendere) attività didattiche pronte da portare in classe. In questo caso, mi riferisco ad un’attività sui minerali. Ti consiglio di andare a dare un’occhiata, magari trovi idee che possono interessarti: https://eduki.com/it/autore/3433188/barbarascapellato